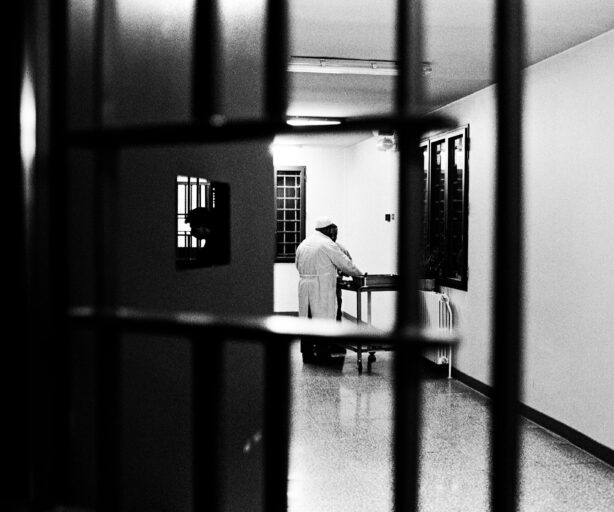
“Su 1.788 persone alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria nel 2024, a fronte di circa 6.800 persone detenute nel Lazio, sono state 69 le persone impegnate nelle lavorazioni, un centinaio nella manutenzione ordinaria dei fabbricati in tutta la regione e altrettante nei servizi extramurari. Il resto svolge attività non qualificate all’interno degli istituti penitenziari. Sappiamo comunque che si tratta di un dato viziato, perché noi sappiamo che, quando parliamo di detenuti lavoranti in carcere, esaminiamo un dato di flusso, non di stato: non è il numero delle persone che lavorano in carcere, ma quello di coloro che, a rotazione, hanno occupato un posto di lavoro nel corso dell’anno o del semestre”.
Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, nel corso dell’incontro “Il lavoro, strumento privilegiato di reinserimento sociale”, che si è svolto martedì 16 settembre, nell’ambito del ciclo organizzato dall’Osservatorio per la giustizia di comunità della Corte d’Appello di Roma.

Il Garante Anastasìa durante il suo intervento.
“Poi c’è il dato delle persone lavoranti per soggetti terzi”, ha proseguito Anastasìa. “C’è stato un calo importante tra il 2021 e il 2022, causato dal Covid, da cui il sistema non si è ancora ripreso. In tutta la regione Lazio nel 2024 risultano solo sei persone dipendenti da imprese, 49 da società cooperative, Sono dati molto bassi. Il lavoro all’esterno impegna 44 persone, escludendo i 39 semiliberi”.
Nel corso del suo intervento, Anastasìa ha spiegato che “purtroppo, nel lavoro in carcere ben poco è cambiato in un decennio. I dati della serie storica dal 2017 al 2024 sui detenuti presenti e sulle persone detenute lavoranti nella Regione Lazio ci dicono che, mentre c’è stata un’oscillazione dei presenti, sostanzialmente dovuta al Covid, riguardo all’attività lavorativa le oscillazioni non sono state particolarmente significative. Un dato sorprendente, però, c’è: il maggior numero di persone occupate in carcere è stato nel 2022, anno del Covid, in cui c’erano meno detenuti”.
La formazione professionale delle persone detenute
Il Garante ha illustrato anche i dati forniti dall’amministrazione penitenziaria relativi alla formazione professionale nel secondo semestre 2024: 19 corsi attivati; 12 terminati; 460 iscritti, di cui 282 nei corsi conclusi, con 276 promossi.
Anastasìa ha definito “disarmante” il confronto con quanto avviene in Lombardia, dove ci sono stati il quintuplo dei corsi svolti nel Lazio, con il doppio degli iscritti.
“La Regione – ha detto Anastasìa – ha una responsabilità nella formazione professionale in carcere, e allora è necessario progettare qualcosa che dia continuità, come le istituzioni scolastiche, che non sia un incidente miracoloso ma possa diventare un fatto strutturale. Inoltre, è fondamentale attivare i servizi per l’impiego all’interno del carcere, che svolgano almeno un bilancio di competenze. Occorre pensare a una presenza stabile dei centri per l’impiego, come previsto dal progetto Ama-De, condiviso dalla Regione Lazio con Sviluppo Lavoro”.
“Sì, molto si è parlato della legge Smuraglia, che è uno strumento molto importante e utile, ma è affidata in gran parte all’attivazione spontanea di soggetti privati, come le cooperative. La responsabilità principale è del ministero della Giustizia, che in 25 anni non ha mai promosso azioni di sensibilizzazione nei confronti delle aziende. La Regione Lazio ha sostenuto un’associazione, Seconda Chance, che ha svolto innanzi tutto un’azione promozionale, informando gli imprenditori dell’esistenza di questo strumento. Questa responsabilità dovrebbe essere assunta soprattutto dai soggetti pubblici, prima di tutto dal ministero della Giustizia. Lo stesso ente Regione – ha concluso Anastasìa – e le sue articolazioni, le sue società partecipate, possono diventare un luogo di inserimento lavorativo per le persone detenute. Anche questo può contribuire a superare le diffidenze di soggetti terzi”.
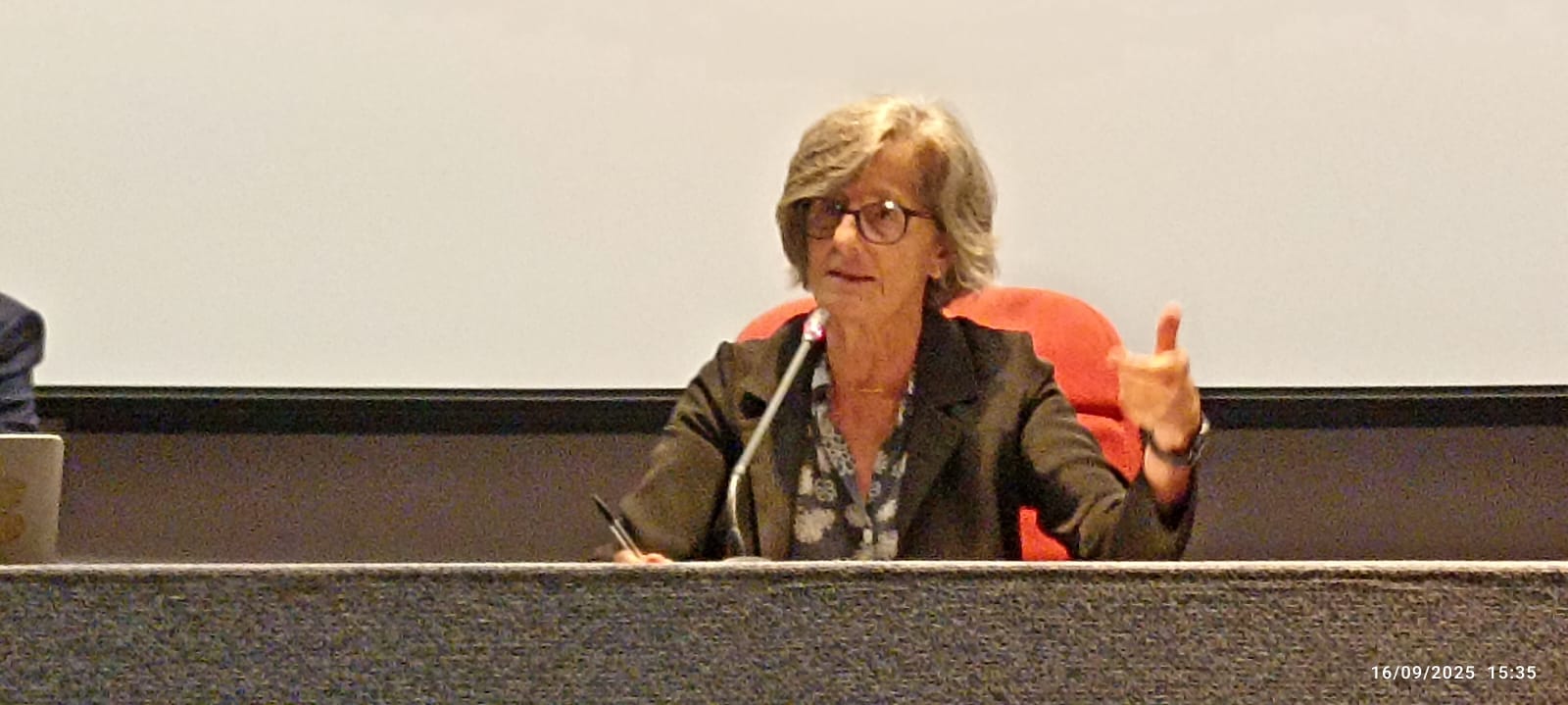
Roberta Palmisano, presidente della Terza sezione penale della Corte d’appello di Roma e coordinatrice dell’Osservatorio per la giustizia di comunità
Il convegno è stato aperto dalla presidente della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma, Roberta Palmisano, coordinatrice dell’Osservatorio per la giustizia di comunità. Sono intervenuti anche: Gherardo Colombo, già presidente della Cassa per le Ammende; David Di Meo, vicecapo dell’Ufficio di gabinetto della Regione Lazio; Stefania Perri, dirigente del Prap Lazio, Abruzzo e Molise; Filippo Giordano, professore ordinario di economia aziendale all’Università Lumsa e membro del segretariato del Cnel; Nunzia Calascibetta, dirigente aggiunto dell’Uiepe di Roma; Luciano Pantarotto, coordinatore GdL Giustizia di Confcooperative Federsolidarietà.
L’Osservatorio della giustizia di comunità, composto da rappresentanti di magistratura, avvocatura, enti locali, ASL e volontariato, si propone di affrontare le criticità attuali attraverso una serie di incontri iniziati all’inizio dell’anno e di elaborare protocolli operativi per definire procedure di intervento efficaci da monitorare nel tempo. Il prossimo incontro, previsto per il 15 ottobre, affronterà il tema della giustizia riparativa.
“La giustizia di comunità – spiega la coordinatrice dell’Osservatorio, Palmisano – può sintetizzarsi nella presa in carico dell’autore di reato e della vittima, e nella organizzazione dei relativi servizi, per valorizzare i percorsi che consentono all’autore di reato di assumere consapevolezza rispetto al fatto-reato, proporre opportunità di cura e sostegno, ma anche occasioni di riparazione. Si presuppone un cambio culturale e una diversa prospettiva, che riguarda soprattutto noi magistrati, perché è a seguito delle nostre decisioni (misure cautelari e condanne) che un cittadino finisce in carcere”.

